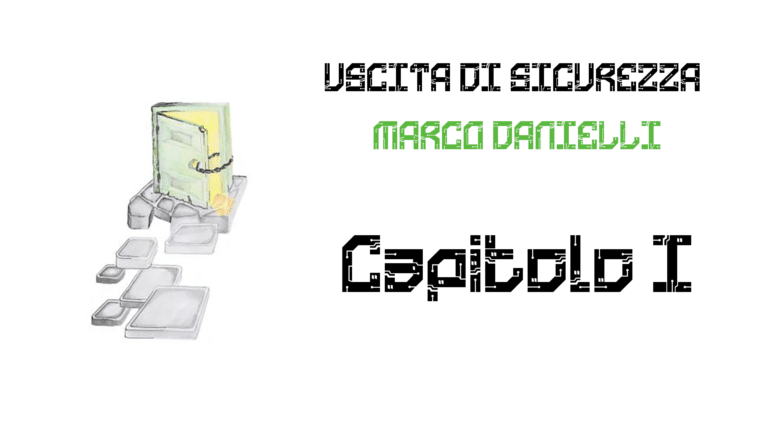Capitolo I
Una strana famiglia la mia: un esempio concreto di come la gente del mondo si mischi senza un criterio logico.
Da parte materna, un nonno genovesissimo che faceva il mediatore in porto, pareva il personaggio di un film: elegante, raffinato, con quell’orologio a cipolla ed i suoi baffetti… una specie di David Niven, insomma. Era un grande cacciatore e infatti, in tempo di guerra, il cibo non fu mai un problema per la sua famiglia, che si era rifugiata sulle Alpi.
Essendo un alpino, sarebbe dovuto partire per la campagna di Russia con la Julia (una di quelle divisioni che non tornarono), quando fortunosamente, durante le visite, un soldato gli disse: «Prendi la mia urina, ho la leucemia: io morirò presto… ma tu hai una figlia…». Fu così che si salvò.
L’addestramento del nipote del grande cacciatore, ossia il mio addestramento, fu precocissimo. Mio nonno e mio padre solevano cacciare i colombacci[1] nei dintorni della Madonna del Monte, uno dei rilievi che cingono Genova a nord, so spingendola in mare; con loro, nelle gelide giornate di tra montana, un esercito di cacciatori aspettava quegli uccelli che, sospinti dal vento, tentavano di superare l’appennino per fermarli, loro malgrado, con un muro di pallini.
Mio padre, dopo avermi per bene imbacuccato, mi infilava nella cacciatora[2] insieme al biberon del latte, e, appostato, sparava ai colombacci; a fine mattinata si ritornava a casa: lui in compagnia di mio nonno ed io dei colombacci morti dentro la cacciatora. Non ricordo, non potrei farlo, quali fossero i miei pensieri in quella situazione: immagino, mi saranno parsi quanto meno un po’… riservati quegli uccelli mezzi spappolati con cui condividevo quel marsupio posteriore!
Rammento ancora il giorno in cui avrei dovuto uccidere la mia prima preda. Il fucile era alto come me: era una doppietta calibro 20, Officine Belga, un gioiello di balistica che straordinari artigiani avevano decorato con figure di fagiani, cani da caccia e uccelli, insomma, un manifesto esplicito delle intenzioni d’uso dell’oggetto. L’arma era dotata di percussori esterni ed era una delle due doppiette in dotazione all’arsenale personale di mio nonno (l’altra era una calibro 12, decisamente più potente e pesante), costituito anche da due fucili mono canna calibro 36 e 22 da uccelletti o, come si diceva… da “signora”!
Il grande vecchio mi diceva: «La vedi quella gazza? Bene, non la puoi sbagliare, sta’ venendo dritta da noi… Ti dico io, quando sparare». La macchia scura era allineata con il mirino; avevo una paura mostruosa, senza contare lo sforzo immane per tenere sollevato quello che per me era una specie di cannone. All’improvviso l’ordine: «Spara!». Chiusi gli occhi, premetti il grilletto e mi trovai a terra con un fischio forte nelle orecchie. In cielo, la gazza che volava tranquilla sopra le nostre teste, incurante della nostra presenza. Non so descrivere lo sguardo di mio nonno: una via di mezzo tra stupore e disprezzo. Indimenticabile.
Comunque i compiti dell’aspirante cacciatore erano anche altri: gettarsi nella boscaglia per stanare le prede e finire gli uccelli feriti, facendogli colpire con la nuca un albero, ed in questi, modestamente, io rasentavo l’eccellenza. Durante il tragitto, per recarci nelle zone di caccia, mio nonno che era uomo dotato di grande fantasia, mi raccontava una quantità di storie inverosimili, che per me però erano assolutamente reali.
Si cominciava con quella di Mario delle volpi, un bambino abbandonato nei boschi, che era stato al levato appunto dalle astute bestiole: «Guarda, c’è Mario delle volpi che ci spia, lo hai visto?», «Ma dove, nonno?» «Laggiù in fondo! Ecco, è scappato. Devi essere più veloce a guardare». Inutile dire che non riuscii mai a scorgere con chiarezza Mario delle volpi, che era un fenomeno di rapidità, anche se ero assolutamente sicuro che quelle ombre e quei fruscii del bosco appartenessero a lui che mi spiava.
Altro cavallo di battaglia di mio nonno era la storia della biscia e dell’orologio. «Devi sapere, che una volta, in montagna, di ritorno dalla caccia, trovai una fontana con la vasca per fare abbeverare le mucche. Faceva un caldo tremendo, così, mi rinfrescai e bevvi, dopo di che scesi a valle. Arrivato in paese mi resi conto di aver perso il mio cipollone e, facendo mente locale, realizzai che non poteva che essere accaduto presso la fontana sul monte, per cui decisi di tornarci la mattina seguente.
Arrivai a mezzogiorno, quando si sentivano le campane dei paesi che suonavano: quando ritrovai il cipollone, segnava proprio quell’ora! Ma come era possibile, mi domandai meravigliato: come faceva a segnare l’ora se nessuno gli aveva dato la corda? Bene, non ci crederai, ma una biscia si era avvolta intorno al pomo della carica e, muovendosi, lo aveva messo in moto».
A volte, per la verità, intuivo che in quelle storie c’era qualcosa che non andava, ma il tono, la convinzione e la naturalezza con cui il nonno me le somministrava erano tali che ne rimanevo affascinato e finivo col trovare che, infondo, una loro logica l’avevano.
Mia nonna invece era una gitana autentica – capelli raccolti col classico grande pettine e occhi nerissimi, di velluto – gran fumatrice e bevitrice; suo padre aveva addirittura una moneta d’oro all’orecchio. Vantava capacità divinatorie, per le quali si avvaleva di tarocchi, pendolino e fondi delle tazzine di caffè.
Di temperamento focoso ed irascibile, talvolta arrivava ad esternarlo fino ad aggredire le persone sia a mani nude, sia con corpi contundenti: suo marito, aveva imparato a schivare sia i piatti, che gli zoccoli di legno che, nei momenti di maggior rabbia, gli scagliava addosso! Si narra di un tentativo di scippo da parte di un tossicodipendente, che fu “salvato” dalla polizia dalle zoccolate della vecchietta in cautamente sottovalutata!
Ricordo che mio nonno mi raccontava delle loro serate da fidanzati, in cucina seduti a tavola conversando l’uno di fronte l’altra con… il mio bisnonno, in silenzio, tra loro. A un certo punto della fantastica serata, lui percuoteva con un pugno il tavolo per far intendere che lo speed date era terminato.
Chi avrebbe potuto immaginare che un giorno sarei andato a cercare queste origini che già allora mi affascinavano? Passando alle ascendenze paterne, invece, vanto un’eroica nonna emiliana, che allevò tra le due guerre due figli da sola, essendo rimasta vedova di uomo che comunque non la aiutava nemmeno da vivo.
Era un’infermiera di sala operatoria, in servizio tutte le notti per lavoro, e con i figli tutti i giorni. Quando ritornava a casa, spesso a piedi (per via dei bombardamenti che bloccavano i tram), dall’ospedale di Sampierdarena, iniziava un giro di iniezioni a domicilio, dormendo quando poteva.
La definirei un esempio inarrivabile di capacità imprenditoriale supportata da una granitica volontà: riuscì ad acquistare ben due appartamenti: «Guarda che io sono andata al cinema una volta sola – ripeteva – e comunque i milioni si fanno con i centesimi». Mio fratello ed io, insieme alle altre sue due nipoti, scoprimmo una volta maggiorenni di possedere diversi milioni di lire, equamente distribuiti, depositati a nostro nome, risparmiati da lei appunto centesimo su centesimo.
Non è mai stata facile la vita per le famiglie operaie, nemmeno nei decantati anni ‘60-’70. Il reddito di mio padre con il suo impiego di autista delle Poste, era largamente insufficiente, pertanto tentava di arrotondare con lavori in nero sempre in regime di sfruttamento estremo – pratica per altro ahimè largamente in uso.
Passava dalla salatura dello stoccafisso, che consisteva nel rimanere con le mani immerse nell’acqua salata per ore, all’impiego come magazziniere in un deposito di parmigiano, dove quotidianamente aveva il compito di ribaltare le forme sugli scaffali: quanto mi incantava osservare mio padre che letteralmente lanciava in aria la forma di parmigiano (anche cinquanta chili di peso!), che si ribaltava come una omelette fatta saltare dalle mani abili di uno chef stellato!
Mia madre invece era una donna molto attraente, capelli corvini e occhi cerulei: una bellezza particolare. Era parrucchiera e si arrangiava a “fare delle teste” in casa. Nonostante i salti mortali per far quadrare i conti, dunque, non ci mancava nulla, e anche la vita forse era più semplice.
Quando all’età di tredici anni già calzavo il 44, mio padre mi passava le sue scarpe usate; ancora oggi che porto il 46, quando acquisto delle scarpe nuove mi dice: «Guarda che se sono strette me le metto un po’, così te le allargo», nonostante io abbia due numeri più di lui.
Il tempo non sa e non può cancellare le abitudini affettive di chi è da sempre abituato a condividere tutto! La tragedia sociale al tempo dei miei anni giovanili coincise con la diffusione esplosiva dell’eroina. Da bambini avevamo cominciato a fumare delle bacche, poi sigarette rubate ai genitori e qualunque cosa fosse combustibile, alghe incluse.
Scoprimmo il fumo che giungeva in quantità e varietà: libano giallo, libano rosso, nero, olio di nero, cioccolato. Mentre giocavo in casa con il mio amico Francesco, lo zio e la mamma confezionavano le bustine di cocaina. «Ragazzi, è pronta la merenda!», si sentiva dire dalla cucina, seguito da un: «Ragazzi, uscite che la mamma deve lavorare…». Stava arrivando il cliente. Povera Gina, emigrata dall’Emilia per finire ad esercitare la professione più antica del mondo a Genova, sola con tre figli, tutti avuti da un padre diverso.
Francesco morì per overdose in galera, e come lui, ma in strada, il fratello maggiore; solo il più stupido dei tre fuggì in Spagna. Francesco, mio coetaneo e compagno di scuola, per noi bambini era un mito: il più sveglio, il più bello, il più deciso, insomma, il nostro leader. Nelle battaglie a sassi e bastonate con i ragazzini di Via Ponterotto sembrava Alessandro Magno alla testa del suo esercito: temerario, pronto ad affrontare le sfide più impossibili, alla bisogna anche impietosamente violento, al contrario di me che, pur essendo più corpulento, se facevo male a qualche bambino scoppiavo a piangere.
Questa sua insensibilità nel picchiare allora era da me considerata una virtù, contrapposta alla mia vigliaccheria… La vita nel branco era spietata: o ti facevi rispettare o soccombevi. Avevo la reputazione di “grande, grosso e abbelinato”, definizione genovese che designa una persona poco sveglia, ma un giorno tutto cambiò. Mio fratello minore subì un’aggressione da parte proprio dei tre figli di Gina, che, come iene, si accanivano a picchiarlo; di impulso, mi gettai a difenderlo, e, magicamente, mi resi conto che ad ogni mio colpo i fratellini stramazzavano a terra.
Mi guardavo incredulo le mani, quasi fossero dotate di un qualche super potere fino ad allora a me sconosciuto: colpivo e loro cadevano, colpivo ancora e loro si accasciavano. Una sensazione bellissima di potenza: ora sapevo che chiunque mi avesse sfidato, sarebbe stato colpito duramente. La rissa si risolse con mio fratello ricoverato all’ospedale con la testa rotta, i fratellini decisamente pesti e sanguinanti; io, che riportavo solo qualche livido, da quel giorno entrai a far parte del gruppo di comando, vista la prova di quanto ero forte e che non avevo paura di dimostrarlo.
Giocavamo in una villa abbandonata dove ora sorge la casa dello studente di Via Asiago; tutto intorno una foresta magica come quella di Peter Pan, roveti gravidi di more, un sacco di materiale abbandonato, utile per costruire capanne: giornate che si volatilizzavano in giochi spensierati, quasi che tutti noi uscissimo da un libro di fiabe. E come nella migliore tradizione, non potevano certo mancare i cattivi: nel nostro caso si trattava di due orchi, lo Gnecco e Zozzolino.
Il primo, in realtà un signore anziano, viveva in un rudere, ricoperto dalle spire di una pianta rampicante, che ci consentiva di andarlo a spiare ed insultare finché ci inseguiva – anzi meglio: ci tirava delle pietre… – per prenderci. Rubargli il suo cimelio – una bandiera italiana con lo stemma sabaudo – fu una delle nostre grandi imprese.
Zozzolino, invece, come dice il nome stesso, era un uomo dall’età e dalle fattezze irriconoscibili, assomigliando più ad un Neanderthal puzzolente, che ad un essere umano. Viveva in un altro rudere insieme ad un cane alla catena, il che gli consentiva una maggiore protezione dalle nostre incursioni che, infatti, non riuscirono mai.
Sorrido oggi, nel ricordare lo stupore con cui, il giorno in cui rompemmo il muro di mattoni di un’altra casa abbandonata, scoprimmo un luogo ai nostri occhi davvero straordinario. Costruimmo delle torce con degli stracci e… fu una visione entusiasmante: maschere, vestiti di scena, sceneggia ture da palcoscenico. Inutile dire che, una volta attrezzati con torce elettriche, quel magazzino teatrale divenne il nostro luogo preferito per giocare, travestirci e nasconderci, fino a quando – fu un giorno tremendo – delle ruspe cominciarono a distruggere la foresta.
Come fieri partigiani ci opponemmo (riuscimmo perfino a rallentare i lavori, inquinando con lo zucchero i serbatoi della benzina dei mezzi), ma fu tutto inutile. Ci ritrovammo così gioco forza relegati a giocare a pallone in un parcheggio, ossia in quello che i sociologi opportunamente definiscono non luogo, dove eravamo tollerati a fatica: Peter Pan aveva perso il suo potere di volare.
Di mia madre ho già detto che era bellissima, ma devo aggiungere che era anche bevitrice, tabagista e cronicamente depressa. A parte quando ci picchiava durante le sue crisi, era una buona madre; con mia nonna aveva invece, purtroppo, un rapporto tanto devastante, che la portò a suicidarsi. Una prima volta mio fratello ed io eravamo riusciti a placcarla al volo, nel suo tentativo di gettarsi dalla finestra (abitavamo al quinto piano); per il secondo tentativo, aspettò di essere sola.
Come è facile immaginare, non fu semplice vivere con una madre così malata: le continue liti e i ricorrenti ricoveri rendevano l’atmosfera familiare oltre modo pesante. E ancora ferocemente vivo in me il ricordo di una visita alla neuro durante una delle sue degenze: l’impatto gelido di quell’immenso corridoio; lei che capiva a fatica e che mi parlava con voce impastata ed occhi vacui, in mezzo a spettrali figure in vestaglia, che si trascinavano con sguardi persi.
Allora forse non capivo nemmeno che era sedata: a me sembrava solo strana e mi disturbava immensamente vederla in quelle condizioni. So che in un periodo particolarmente critico mi augurai perfino che morisse; quando poi accadde veramente, non dormii più, tanto mi sentivo responsabile. Avevo undici anni. Credo che superai lo scoglio di quella cruda esperienza grazie a mio padre, un fenomeno di pedagogia istintiva: lui mi ha sempre fatto sentire importante, adulto, lasciandomi la massima libertà con il massimo dialogo.
Per mio fratello, ancora troppo piccolo, invece lo scoglio fu insormontabile. Si rifugiò in una infanzia perpetua; troppo forte il dolore di crescere, troppe le botte prese durante le crisi di mia madre. Tra i medici ci fu chi parlò di autismo, chi di qualcos’altro: sostanzialmente fuggì da un mondo degli adulti troppo doloroso; io non fui in grado di aiutarlo; del resto, fuggivo anch’io, lasciandolo solo, indifeso, inaugurando la lunga serie di fughe della mia vita. Scusa fratello.
Passavano gli anni e impazzava la new wave, con la musica dei Simple Minds, dei Soft Cell, dei Cure, dei Cult. Ci vestivamo di nero come becchini e trascorrevamo interi pomeriggi in discoteca nella vana speranza rimediare qualche ragazza. Come sono finiti i ragazzi della mia via? Qualcuno morto di overdose o in galera, pochi disintossicati e alcuni miracolati, guarda caso i meno brillanti.
La mia vita era scandita dai tempi della scuola e dalle canne; avevo capito molto presto che non abbiamo tutti le stesse opportunità nella vita per cui, se nasci operaio, difficilmente sarai qualcosa di diverso; io ero perennemente con la testa tra le nuvole, sognavo continuamente altre vite, per me doveva essere diverso.
Mio padre, autista delle Poste, si arrangiava come poteva a tirare avanti; ricordo le discussioni con i suoi amici operai, notavo una vasta adesione al movimento delle Brigate Rosse (gli operai vivevano male, senza sbocchi per il futuro, guardavano i figli e vedevano altri operai condannati alla loro stessa vita grama e allora, chi l’ha detto che non si poteva cambiare? Se il cambiamento deve passare per la lotta armata, sia).
Non mi parevano scandalizzati quando venivano gambizzati i magistrati o i giudici; il dissenso era nel colpire i morti di fame come loro, i poliziotti, i giornalisti, i sindacalisti, sino alla completa consapevolezza che anche la rivoluzione era stata un miraggio sapientemente gestito dagli stessi che si doveva combattere.
Non comprendevo pienamente tutto quel fervore; mi sembrava fosse giusto provarlo, solo che io non ci riuscivo; imitavo i gesti e le parole gli sguardi di mio padre e dei suoi amici, ma intimamente mi dicevo che forse il mondo era giusto così come era. Ci sarà stato un motivo se non esisteva l’uguaglianza! E fuggivo via.
Al cimitero di Staglieno lavorano tre squadre di becchini, che assolvono ai tre servizi forniti: inumazione, esumazione e tumulazione. Quest’ultimo è riservato ai becchini anziani, in quanto viene svolto senza sporcarsi: sostanzialmente il feretro viene trasportato in prossimità del loculo o della tomba di famiglia e, dove è possibile, posizionato con degli appositi sollevatori; il tutto avviene al riparo dalla pioggia, dato che i tumuli sono all’interno di gallerie. Inoltre, grazie alla mediazione dell’Impresa di Onoranze Funebri che segue i familiari, le mance sono decisamente più alte; si può pertanto sicuramente affermare che, a meno di diventare “capo becchino”, il servizio al carretto è un punto di arrivo nella carriera.
Le due restanti squadre si alternano nei servizi di inumazione ed esumazione a cadenza settimanale. Il primo funziona in questo modo: arrivata la salma in prossimità del campo viene trasportata a braccia ai margini della fossa preventivamente preparata con un escavatore, quindi calata in quattro persone. Terminate le eventuali onoranze, i becchini iniziano a coprire la cassa a mano – l’escavatore completerà l’operazione – ed il cumulo di terra informe verrà modellato anch’esso a mano, in attesa che si assesti.
Non per vantarmi ma come modello i blocchi di terra io con la zappa, non li modella nessuno. Sembra banale, ma noi utilizziamo una zappa a tre rebbi che consente di prendere molta terra; ora, quando la terra è umida, la si riesce a prelevare a blocchi e, con sapienti gesti, a collocarla nei punti giusti del cumulo sino a dargli una forma trapezoidale precisa, il tutto in pochissime zappate.
La mia squadra è costituita da Mugabi and the mallochs (Mugabi e i mallocchi), in virtù della quantità di terra che riesco assestare sul cumulo, che fa esclamare: “Sei proprio una bestia!”. Il mio appellativo, Mugabi, de riva dal nome di un pugile di colore detto appunto “Mugabi the beast” e i mallocchi sono i miei compagni di squadra. Il servizio di esumazione invece è l’estrazione dei resti, dopo sette anni di sepoltura. In linea teorica dovrebbero essere mineralizzati, ma spesso sono indecomposti.
L’operazione si svolge a mano, la salma dopo essere stata esposta dall’escavatore viene estratta dal becchino a mano. Il problema è che d’estate il caldo, le zanzare tigre e l’odore di decomposizione ti torturano, mentre in inverno la fossa si riempie di una fanghiglia puzzolente che non puoi evitare, in quanto ti devi calare nella fossa e, pur con stivali e tuta di protezione, operare tra ossa galleggianti non è il massimo della vita…
Quando i carri funebri devono entrare al cimitero, gli autisti scendono dalle auto per consegnare i documenti relativi alla salma e contemporaneamente una campana risuona, allertando gli operatori che bisogna scaricare, in una apposita cappella, il feretro.
Gli arrivi sono in genere verso metà mattinata per cui vi è una pausa tra le inumazioni del mattino e quelle successive; questo è il momento in cui generalmente il personale va a bere fuori dal cimitero ad un chiosco gestito con il figlio dalla Terre, o Teresa, signora che conosce le vite di tutti i becchini e ne allevia le sofferenze con bianchi amari o grigioverdi; in pratica vino bianco e amaro e grappa con la menta.
Il chiosco sembra una mostra fotografica dedicata ai becchini; è tutto tappezzato di fotografie, che, negli anni, il personale del cimitero si è fatto scattare, per cui è un po’ un luogo della memoria. Guardi quelle facce disfatte, quegli sguardi vacui, quegli indumenti larghi e ti ricordi da dove vieni, chi sei e immagini quello che diventerai. Non sopporto il chiosco della Terre e neppure i miei colleghi con i loro soliti discorsi in genovese sul Genoa o la Sampdoria, ma oggi c’è una novità: un ragazzo con il basco amaranto sta salutando il figlio della Terre, sarà un militare di leva nei paracadutisti, sembra entusiasta.
Io non ho fatto il militare e penso subito che mi sarebbe piaciuto; mi leggevo riviste come Raide, fumetti di guerra, ma purtroppo un giorno arrivò la lettera di esuberanza di leva. Tutti mi dicevano: “Che culo, non parti, te ne stai a casa!”. Sì a casa… Un senso di angoscia mi pervade; devo andare via, defilarmi.
Percorro tra le tombe di famiglia abbandonate, il viottolo che porta alla ex casa del custode, sposto la catena che chiude la porticina di legno marcio che permette l’accesso al cortiletto interno. Un lampo di luce mi avvolge ed entro. Sì, perché all’interno del cortiletto nel tepore del sole l’affanno cessa, sono al sicuro.
Mi sento al sicuro. Mi rilasso e, seduto sul mio ceppo, mi rollo la mia canna come uno sciamano che si appresta ad officiare un rito pagano. La mente si perde nelle forme disegnate dal fumo che si espande intorno e…
USCITA DI SICUREZZA
Note:
[1] Colombi selvatici cacciati durante le migrazioni
[2] Tasca posteriore dell’indumento per la caccia, che serve per riporre la prede