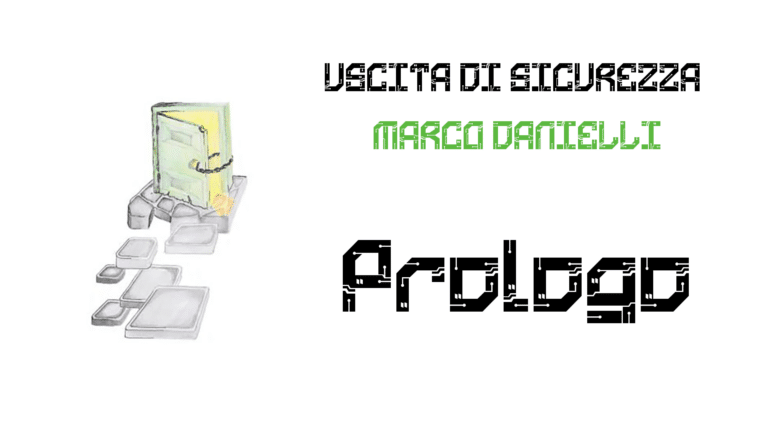Prologo
È ancora buio, davanti all’ingresso del cimitero monumentale di Staglieno un piccolo gruppo di anziani chiacchiera in attesa dell’apertura dei cancelli. Anch’io sosto, insieme a loro, in attesa che si apra l’enorme portone metallico, preludio del mio limbo quotidiano.
Sì, perché lavorare a Staglieno è proprio come vivere in un limbo, un luogo fuori dal tempo e dalla realtà. Dicono che Staglieno, il Camposanto di Genova, sia il cimitero monumentale più grande di Europa, una sorta di strano e romantico museo dell’arte borghese della seconda metà dell’Ottocento.
Camminare tra i folti viali e le gallerie che lo disegnano, lungo la collinache gli fa da sfondo, suscita grande impressione e fascina-zione, proprio come testimoniano i racconti degli illustri viaggiatori e artisti che lo hanno visitato nel tempo. Le dimensioni enormi, le altissime mura di cinta e le architetture imponenti creano suggestioni rare, tutto vive, tutto vibra dentro il Tempo e se questo si blocca fa sì che ogni cosa sia e non divenga più.
In inverno, poi, quando il cimitero è ancora chiuso, passeggiare tra le tombe monumentali è un’esperienza surreale: nel silenzio assoluto le statue antropomorfe, al balenare dei riflessi dei ceri, sembrano quasi muoversi…, è come se rientrassero da chissà quale sabba notturno e si riposizionassero su loro piedistalli per la consueta finzione diurna agli umani.
Mi sforzo di fare il mio dovere nel migliore dei modi, anche se è più che evidente che fare l’operatore cimiteriale seppellitore, il becchino insomma, non possa proprio considerarsi un’attività gratificante; inoltre, non si può certo dire che io abbia mai socializzato più di tanto con i miei colleghi… direi che non mi considerano proprio.
Quando il lavoro, i rapporti personali e le vicende private si presentano dolorosamente crudeli alla mia coscienza e le chiedono attenzione mi rifugio “nella casa”, immersa tra gli alberi, dove un tempo viveva un custode.
Ora è una struttura pericolante ed anche il percorso per accedervi è dissestato, tanto che per giungervi bisogna oltrepassare una specie di selva, dopo la quale appare una porta di legno chiusa da una catenella; da lì si accede ad un piccolo cortiletto in terra battuta, che si è tramutata in un prato. Questo spazio è cintato da un muro che impedisce al vento di entrare e l’ingresso della casa è esposto a sud, pertanto, gode della luce migliore.
Appoggiato alla parete vi è un ceppo di legno che uso come poltrona: è proprio lì che mi siedo, a godermi il sole sul viso. Poi il rito: estraggo un po’ di tabacco ed il pezzettino di carta stagnola contenente il fumo e, con gesti lenti, misurati e quasi solennimi rollo la mia canna. Inizio a fumare, osservando le figure disegnate dal fumo nell’aria, chiudo gli occhi e viaggio via.
Sono nell’ombelico del mondo, nell’occhio del ciclone attorno al quale tutto ruota vorticosamente, mentre io mi libro in un’assoluta calma piatta, in una totale assenza di vento. E, intrappolato tra passato e presente, in questo posto così isolato e assurdo finalmente vivo quello che avrei potuto essere, e costruisco le mie vicende parallele. Quell’uscio di legno è la fuga dalla mia quotidianità allucinante, è:
L’USCITA DI SICUREZZA.