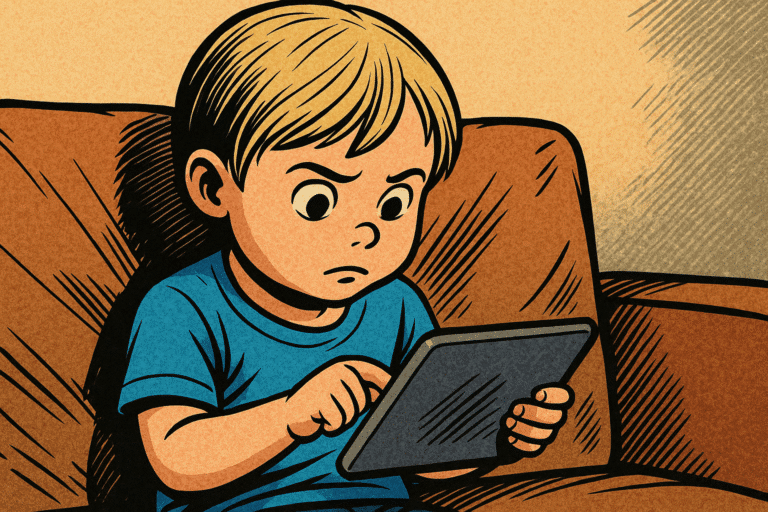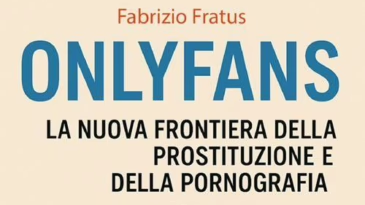“iPad kids”: una nuova, fragile, identità digitale
La Generazione Alfa[1], comprendente i nati tra il 2010 e il 2025, rappresenta un fenomeno socioculturale inedito, ovvero la prima infanzia della storia vissuta interamente all’interno dell’ecosistema digitale.
Sono bambini che hanno familiarità con tablet e smartphone fin dalla più tenera età e per i quali l’esperienza collettiva del lockdown, durante la pandemia di Covid-19, ha ulteriormente rafforzato il legame con i dispositivi elettronici, rendendoli non solo strumenti di svago ma anche di apprendimento, socializzazione e rifugio.
Non sorprende che siano stati etichettati, non senza una punta di ironia critica, come “iPad Kids”, definizione che sintetizza la loro immersione quotidiana nei contenuti digitali e sottolinea il rischio di come l’universo mediatico possa sostituire gradualmente le forme tradizionali di gioco e di conoscenza. L’accesso costante al digitale spalanca possibilità educative straordinarie[2], rendendo disponibili risorse didattiche personalizzabili e percorsi di apprendimento innovativi, ma al tempo stesso solleva interrogativi profondi sulla qualità dei contenuti e sull’assenza di filtri realmente efficaci.
In passato i programmi televisivi destinati ai più piccoli erano spesso frutto di un lavoro di consulenza pedagogica e psicologica volto a garantire un linguaggio comprensibile e messaggi adeguati all’età, mentre oggi piattaforme quali YouTube non dispongono di analoghi meccanismi di controllo, affidando alla logica algoritmica la selezione di ciò che appare sullo schermo dei bambini. Nonostante l’esistenza di YouTube Kids, presentata come ambiente protetto, numerosi scandali hanno messo in evidenza i limiti di simili sistemi: il caso noto come Elsagate ha mostrato come video apparentemente innocui potessero in realtà contenere elementi disturbanti ed inadatti a un pubblico infantile[3].
Ulteriore elemento di preoccupazione riguarda le conseguenze cognitive e comportamentali di questa nuova “dieta digitale”: i contenuti online sono spesso costruiti su ritmi accelerati e su strategie mirate a catturare l’attenzione il più a lungo possibile. Per un adulto tali logiche sono già difficili da riconoscere e governare, ma per un bambino diventano pressoché invisibili ed irresistibili. Non a caso, diverse ricerche hanno segnalato un progressivo declino delle capacità di concentrazione[4] e di memoria tra i più giovani: in Inghilterra, un’indagine condotta tra gli insegnanti ha rivelato che quasi sette docenti su dieci hanno osservato, soprattutto dopo il periodo pandemico, un incremento di episodi di disattenzione e di “sogni a occhi aperti” tra gli studenti[5].
Il lockdown, infatti, ha non solo aumentato le ore trascorse davanti agli schermi, ma ha anche introdotto nuove abitudini culturali: durante la pandemia, piattaforme quali TikTok hanno conosciuto una popolarità senza precedenti, diventando strumenti di intrattenimento quotidiano per due adolescenti su tre, con conseguenze che oggi si misurano nella difficoltà a gestire periodi prolungati di concentrazione[6]. È significativo anche l’emergere di un’abitudine particolare: l’uso sistematico dei sottotitoli anche per contenuti in lingua madre, adottati come espediente per non distrarsi e per mantenere l’attenzione fissa sullo schermo, quasi a conferma di una costante tensione verso la dispersione.
L’insieme di tali fattori contribuisce a delineare un mutamento radicale nel concetto stesso di infanzia: le esperienze di socialità diretta, il gioco libero all’aperto, l’esplorazione spontanea dell’ambiente fisico e la capacità di affrontare la noia vengono progressivamente soppiantate da interazioni virtuali e da mondi mediati da uno schermo. Secondo numerosi pedagogisti, la mancanza di gioco fisico e di relazioni faccia a faccia compromette lo sviluppo di competenze emotive e relazionali che non possono essere sostituite da esperienze simulate. Una situazione ulteriormente aggravata da un’educazione familiare che, sempre più spesso, appare divisa tra iperprotezione e permissività: da un lato vi è il timore di essere considerati genitori troppo autoritari, dall’altro la scelta, apparentemente più comoda, di affidare il figlio al dispositivo elettronico, che diventa così una sorta di babysitter digitale. Come conseguenza, il ruolo dell’adulto educatore tende a diventare periferico, se non del tutto invisibile, nel vissuto quotidiano dei bambini, con implicazioni che emergeranno in modo ancora più evidente quando i ragazzi entreranno nell’adolescenza.
Eppure, la Generazione Alfa non è soltanto fragilità. Diversi studi sottolineano come questi bambini mostrino anche tratti distintivi positivi[7]: una quota significativa di loro, stimata intorno al 40%, manifesta già un interesse concreto per la salvaguardia del pianeta e per pratiche di consumo responsabile[8]. La precoce esposizione a universi digitali non filtrati rischia tuttavia di accelerare processi di alienazione nei quali la realtà virtuale appare più attraente e gestibile rispetto alla complessità delle relazioni umane. Non sorprende, quindi, che fenomeni quali le dirette “NPC”, in cui i personaggi ripetano gesti suggeriti dal pubblico, o i video di Roblox costruiti sulle interazioni dei commenti, godano di straordinaria popolarità tra i giovanissimi, i quali vi trovano una forma di interazione semplificata ed immediatamente gratificante.
La questione non può però certo essere liquidata con una condanna generica della tecnologia: gli strumenti digitali restano risorse potenti e potenzialmente arricchenti, in grado di ampliare le possibilità educative e di stimolare nuove forme di creatività. Il problema, semmai, risiede nell’uso inconsapevole ed incontrollato, che finisce per trasformare un’opportunità in un rischio. Occorre perciò promuovere un approccio equilibrato, che preveda limiti chiari, ma non dogmatici, favorisca la fruizione di contenuti di qualità e riaffermi il valore insostituibile del tempo trascorso fuori dallo schermo. La responsabilità è condivisa: genitori, educatori ed istituzioni devono collaborare per creare ambienti digitali sicuri e per sostenere un’educazione che integri il digitale senza ridurre il bambino a semplice “consumatore di contenuti”.
Il futuro della Generazione Alfa dipenderà in larga parte dalle scelte di oggi: evitare la tecnologia o demonizzarla significherebbe condannarsi ad un anacronismo sterile; abbracciarla senza comprenderne i meccanismi significherebbe, al contrario, abdicare il ruolo educativo. La sfida è costruire una cultura del digitale che sappia trasformare i rischi in opportunità, preservando le dimensioni umane della crescita.
Note e riferimenti bibliografici:
[1] https://www.businessintelligencegroup.it/quando-inizia-la-generazione-alpha-unanalisi-approfondita-di-business-intelligence-group-esperti-in-ricerche-di-mercato/
[2] https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/189559
[3] Balanzategui, J. (2019). Examining the “Elsagate” phenomenon: disturbing children’s YouTube content and new frontiers in children’s culture. Selected Papers of Internet Research 2019.
https://www.researchgate.net/publication/343406513_EXAMINING_THE_ELSAGATE_PHENOMENON_DISTURBING_CHILDREN%27S_YOUTUBE_CONTENT_AND_NEW_FRONTIERS_IN_CHILDREN%27S_CULTURE
[4] https://www.twinscience.com/en/blog/short-attention-span-in-children-symptoms-and-ways-to-improve/
[5] The Guardian. (2023, June 7). Children’s attention span ‘shorter than ever’ since Covid crisis, say teachers in England.
https://www.theguardian.com/education/2023/jun/07/children-attention-span-shorter-covid-crisis-teachers-england-primary
[6] Parkin, J., & Pardhan, S. (2022). Risks of digital screen time and recommendations for mitigating adverse outcomes in children and adolescents. Journal of School Health, 92(9), 765–775.
[7] https://www.ninja.it/generazione-alpha/
[8] Parliament UK Education Committee. (2024, May 25). Screen time: impacts on education and wellbeing. House of Commons.
https://publications.parliament.uk/pa/cm5804/cmselect/cmeduc/118/report.html