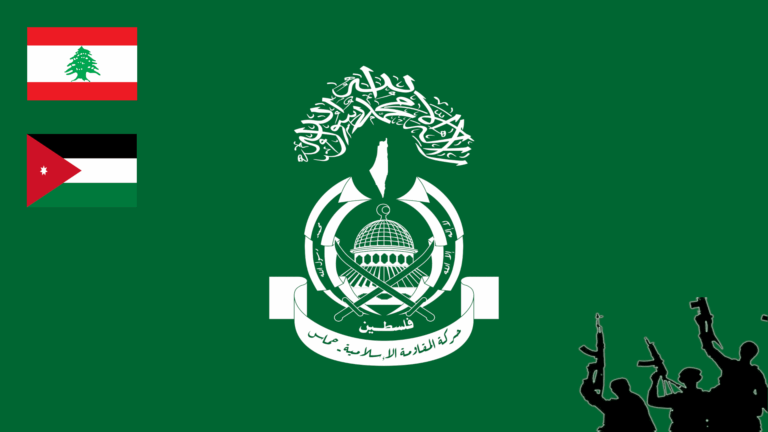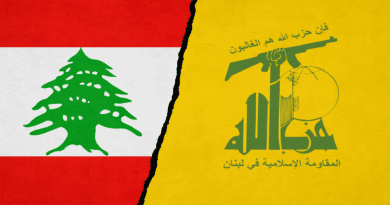Hamas: gli albori della politica internazionale
L’ascesa e la sopravvivenza di Hamas, come avviene per molte organizzazioni non statali, sono state in larga parte influenzate dalle scelte e dalle strategie adottate da vari stati. A seconda del contesto politico, i governi hanno alternativamente visto nel movimento islamista un ostacolo, una minaccia, un problema da gestire o persino una leva da sfruttare.
Libano
Un episodio emblematico di questo paradosso si verificò nel 1990, quando una decisione del governo israeliano finì involontariamente per offrire a Hamas un punto d’appoggio fuori dai Territori Palestinesi. In risposta alla crescente percezione del movimento come un pericolo concreto – dopo anni in cui era stato tollerato – Israele decise di espellere quattro membri di Hamas da Gaza, trasferendoli nel sud del Libano il 29 dicembre di quell’anno, senza consultare le autorità locali.
I militanti si stabilirono nei pressi di Sidone, nel piccolo campo profughi di Mieh wa Mieh, situato vicino ad Ain al-Hilweh, il più grande tra quelli istituiti in Libano per accogliere i rifugiati palestinesi fuggiti nel 1948; i quattro deportati assunsero rapidamente un ruolo di leadership, imponendosi come guida religiosa e politica all’interno del campo.
In un contesto segnato da condizioni di vita estremamente difficili – sovraffollamento, miseria e marginalizzazione – Hamas iniziò a diffondere il proprio messaggio, cercando consensi tra una popolazione disillusa e vulnerabile. A questa prima ondata seguirono, nel 1992, altri 415 attivisti espulsi da Israele ed inviati anch’essi in Libano.
L’eco del messaggio di Hamas non tardò ad attirare l’attenzione di alcune realtà sunnite libanesi, come Jama’a al-Islamiya ed al-Ahbash, che si mostrarono sensibili alla visione ideologica del movimento. In quegli anni, con le altre fazioni palestinesi indebolite dai conflitti interni e dalla lunga guerra civile libanese, Hamas seppe colmare il vuoto lasciato nel panorama politico e militante palestinese in Libano.

Due dei primi deportati assunsero in seguito incarichi di primo piano all’estero: Imad al-Alami venne nominato rappresentante di Hamas in Iran, mentre Mustafa al-Qanuaa fu designato a guidare l’ufficio politico del movimento a Beirut. L’interesse di Hamas per la diaspora palestinese in Libano si inseriva in una più ampia strategia di espansione e legittimazione, in un momento in cui molte delle tradizionali formazioni palestinesi stavano perdendo terreno.
Negli anni successivi alla sua fondazione, Hamas si affermò come un polo d’attrazione per i palestinesi residenti nei campi profughi del Libano, iniziando così a rappresentare un’alternativa concreta alla leadership di Fatah. Mentre molte delle fazioni rivali contavano su sostenitori meno ideologicamente impegnati – spesso spinti più dall’incentivo economico che da una vera adesione politica – Hamas ed altri gruppi islamici guadagnavano terreno grazie ad una rete capillare di iniziative sociali. Questi movimenti religiosi si distinguevano per l’organizzazione di servizi di assistenza destinati ad orfani e vedove, la gestione di scuole ed asili, la costruzione di moschee e l’offerta di corsi professionali per donne, finalizzati a favorire l’autonomia economica domestica.
In passato, era l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) a beneficiare di un ampio consenso popolare grazie ai fondi utilizzati generosamente per sostenere questi progetti. Tuttavia, dopo l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq il 2 agosto 1990, i Paesi del Golfo – contrari all’allineamento dell’Olp con Baghdad – decisero di interrompere il sostegno economico garantito sin dagli anni Sessanta. A quel punto, le organizzazioni caritative della regione trasferirono il proprio sostegno finanziario e simbolico verso Hamas, ritenuto un attore più meritevole e coerente sul piano ideologico.
Giordania
Fino alla prima Intifada, esplosa nel 1987, i Fratelli Musulmani non avevano mai incluso la lotta armata tra le proprie priorità strategiche. La nascita di Hamas, con il suo orientamento militante, costrinse la sezione giordana del movimento islamico – a cui era affiliata anche quella attiva in Cisgiordania – a riconsiderare la propria posizione. Era necessario stabilire se l’attività armata promossa dal nuovo gruppo fosse compatibile con la vocazione sociale, educativa e religiosa su cui i Fratelli Musulmani avevano sempre fatto leva.
Durante gli anni dell’Intifada, il consenso popolare crescente spinse Hamas a ristrutturarsi, includendo al proprio interno una divisione per gli affari esteri. Fu questo il momento in cui la dirigenza si sentì pronta a svincolarsi formalmente dal movimento madre, diventando un’entità autonoma. L’apertura di un ufficio politico ad Amman rappresentò un passaggio cruciale: i contatti con le autorità giordane avvenivano attraverso i canali dei servizi di intelligence. Con lo shaykh Ahmad Yassin detenuto in Israele, la guida del movimento passò a Musa Abu Marzuk che, espulso da Gaza nel 1989, si era stabilito in Giordania.

Sul piano politico, i rapporti con il governo giordano risultavano in quel periodo relativamente distesi. L’invasione del Kuwait da parte delle forze irachene aveva infatti costretto diversi leader di Hamas a lasciare l’emirato ed a trovare rifugio ad Amman. In molti osservatori, all’epoca, si fece strada l’idea che la monarchia hashemita considerasse Hamas un possibile strumento di leva nei confronti dell’Olp, da utilizzare in eventuali tensioni future con l’organizzazione di Arafat.
Le frizioni con la monarchia hashemita
I primi segnali di frizione tra Hamas ed il governo giordano emersero quando la leadership del movimento islamista decise di coordinare da Amman alcune operazioni nei Territori Occupati, senza però informare né le autorità locali né la branca giordana dei Fratelli Musulmani. La tensione salì nel 1991, quando le forze di sicurezza giordane scoprirono un consistente arsenale nascosto in quattro località diverse della capitale. Il ritrovamento, che includeva mitragliatrici e cannoni per un valore stimato di circa un milione e mezzo di dollari, colse di sorpresa sia Hamas sia i Fratelli Musulmani giordani.
L’episodio portò all’arresto di nove militanti di Hamas, detenuti per nove mesi e successivamente graziati dal re nel 1992. Questo episodio segnò una svolta nei rapporti tra il regno hashemita ed il movimento palestinese: le autorità di Amman iniziarono ad esercitare un controllo più stringente su Hamas, riducendo progressivamente la tolleranza nei confronti delle sue attività sul territorio.
Nel tentativo di regolare i rapporti, nel 1993 si tennero incontri formali tra esponenti di Hamas — tra cui Abu Marzuk, Ibrahim Ghosheh, Muhammad Nazzal ed Imad Alami — ed alti rappresentanti del governo giordano, incluso il primo ministro Zaid bin Shaker. Le discussioni proseguirono anche presso la sede dei servizi segreti, dove fu stabilito con chiarezza che, entro i confini giordani, Hamas avrebbe potuto condurre soltanto attività politiche e di propaganda, purché non contrarie agli interessi nazionali. Ogni forma di attività militare venne categoricamente vietata.
Le preoccupazioni delle autorità giordane aumentarono nel 1995, quando furono sequestrati CD contenenti informazioni dettagliate sull’organizzazione interna di Hamas a Gaza ed in Cisgiordania. A seguito di questa scoperta, le misure repressive si intensificarono, con nuovi arresti tra i ranghi del movimento.

Nel frattempo, Hamas iniziava a rivendicare attentati in territorio israeliano, analogamente a quanto fatto da Fatah negli anni Sessanta. La firma del trattato di pace tra Giordania ed Israele nel 1994 complicò ulteriormente i rapporti: Abu Marzuk ed Imad Alami vennero espulsi dal paese. Marzuk fu successivamente arrestato negli Stati Uniti con l’accusa, mai dimostrata, di coinvolgimento in attività terroristiche. Nonostante le tensioni, re Hussein intervenne a suo favore, facilitando il suo rientro in Giordania nel 1997, autorizzando il rimpatrio dagli Stati Uniti.
L’operazione segreta del Mossad in territorio giordano segnò una svolta nei rapporti tra la Giordania e Hamas. Quando gli agenti israeliani tentarono di assassinare Khalid Mishal ad Amman, Tel Aviv inizialmente negò ogni coinvolgimento. Re Hussein, però, reagì con fermezza, definendo Mishal «uno dei nostri figli» e ventilando, durante colloqui informali con giornalisti locali, la possibilità di eseguire la condanna a morte dei due agenti catturati. Paradossalmente, l’azione del Mossad era stata concepita proprio per evitare di mettere in difficoltà il governo giordano.
Nonostante l’intervento diretto del sovrano in difesa del leader islamista, i rapporti tra Hamas e le autorità di Amman andarono progressivamente deteriorandosi. Un elemento chiave del crescente attrito fu la tensione interna tra Hamas e la filiale giordana dei Fratelli Musulmani, tradizionalmente più vicina alla monarchia. La leadership dei Fratelli, rappresentata dal capo egiziano Mustafa Mashur, manifestava crescente disagio per l’autonomia decisionale di Mishal, che agiva in Giordania senza previa consultazione.
Nel corso del 1999, la situazione degenerò: i servizi segreti giordani arrestarono diversi membri di Hamas appartenenti al cosiddetto gruppo di al-Rasifa, suscitando irritazione tra i vertici della Fratellanza. A questi fermi si aggiunsero, a metà anno, quelli di due guardie del corpo di Mishal, accusate di porto illegale d’armi.
La chiusura della sede di Amman
Il 29 agosto 1999, il governo giordano annunciò ufficialmente la chiusura dell’ufficio politico di Hamas ad Amman, il divieto delle attività del movimento sul territorio nazionale e l’emissione di un mandato d’arresto nei confronti di Mishal e dei suoi collaboratori. La reazione non tardò ad arrivare: tre settimane più tardi, la branca giordana dei Fratelli Musulmani mobilitò la propria base, coinvolgendo partiti e sindacati in una campagna di protesta contro la decisione governativa.

Nel frattempo, Mishal, insieme ad altri due dirigenti di Hamas, si trovava a Teheran. Di fronte all’escalation, il gruppo scelse di spostarsi a Damasco per riflettere sulla crisi ed evitare un confronto diretto con Amman.
La rottura con la Giordania rappresentò un punto di non ritorno nei rapporti tra il regno hashemita e Hamas, segnando la fine di una fase di dialogo e collaborazione che, fino a pochi anni prima, sembrava consolidata. Basti pensare che in tempi più distesi, personalità di spicco come Mousa Abu Marzouk potevano contattare direttamente re Hussein su una linea telefonica riservata. Il progressivo isolamento dell’ufficio politico in esilio contribuì ad un cambiamento interno: la leadership effettiva del movimento cominciò a spostarsi verso Gaza, dove si concentravano sempre più risorse e consenso.
Riferimenti bibliografici:
- https://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7260:gli-avvelenamenti-segreti-di-israele-nel-1948&catid=90&Itemid=532
- https://www.invisiblearabs.com/2012/01/30/lincontro-di-amman-e-la-trasformazione-di-hamas/
- https://ilcaffegeopolitico.net/984425/hezbollah-dalle-origini-alla-guerra-tra-israele-e-hamas
- https://pilloledistoriaefilosofia.com/2025/04/13/la-storia-di-hamas-dalle-origini-agli-attacchi-dellottobre-2023/
- https://pagineesteri.it/2025/04/18/primo-piano/da-capro-espiatorio-alla-fratellanza-al-ghetto-la-storia-dei-palestinesi-in-libano/
- https://iari.site/2023/10/25/levoluzione-di-hamas-e-hezbollah-e-linfluenza-iraniana/
- https://www.dellaportaeditori.it/marginalia/la-storia-del-conflitto-israelo-palestinese/
- https://www.cespi.it/it/eventi-note/articoli/medio-oriente-una-lunga-storia
- https://www.italianieuropei.it/la-rivista/item/1027-du-d%C3%A9j%C3%A0-vu-in-libano.html
- https://iari.site/2023/11/09/breve-storia-di-hamas/
- https://www.wired.it/article/giordania-palestina-israele-hamas-conflitto/
- https://storiainpodcast.focus.it/la-caccia-ai-leader-di-hamas-in-giordania/