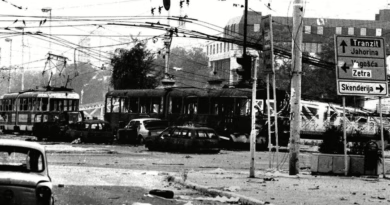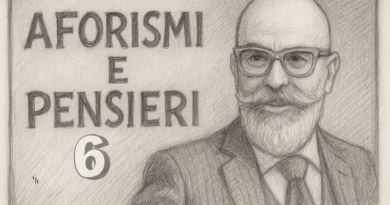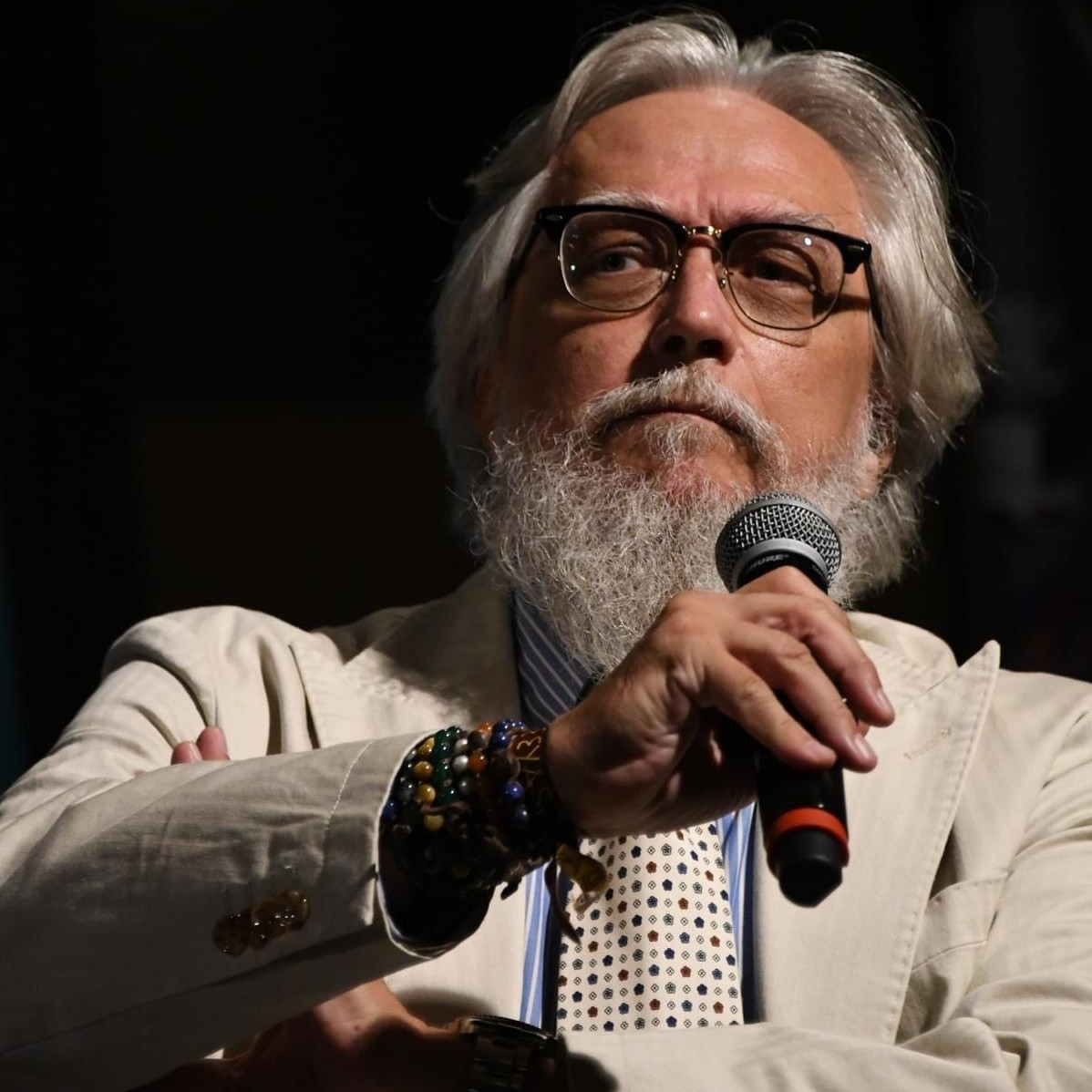Come nasce lo Stato?
Ovvero la più forte di tutte le organizzazioni umane.
Secondo l’Enciclopedia Treccani lo Stato è:
“Una comunità politica costituita da un popolo stanziato in un determinato territorio e organizzato unitariamente come persona giuridica collettiva, e titolare di un potere sovrano (governo), cui è riservato il monopolio dell’uso legittimo della forza (potere coattivo), allo scopo di garantire l’ordine pubblico interno e di assicurare la difesa contro eventuali nemici esterni.”
Per semplificare possiamo dire che lo Stato è la suprema forma di organizzazione umana. Ad oggi tutte le altre istituzioni sperimentate sono state superate in forza ed efficienza (sia chiaro, anche efficienza in negativo) dal concetto di Stato, mentre quelle sovranazionali, quali l’ONU e l’Unione europea, non hanno mai raggiunto la capacità degli Stati di governare gli uomini. Persino la Svizzera, questa piccola e meravigliosa eccezione planetaria, che nacque come alleanza militare, ovvero come uno specifico tipo di struttura sovrastatale, nel progredire della sua storia per sopravvivere dovette trasformarsi in uno Stato vero e proprio, per quanto caratterizzato da un forte decentramento federale (che gli elvetici abbiano trovato la “formula magica”?).
Ma come nasce uno Stato? Cosa ha portato gli uomini del neolitico a superare il livello di clan e tribù?
Le prime forme di statualità nascono con l’agricoltura, la quale obbligò i nostri antenati ad un’esistenza stanziale in loco di quella nomade e generò un surplus di risorse. L’esistenza stanziale a sua volta impose la necessità di difendere le proprie case ed i propri raccolti dai nomadi e da altre società agricole, cosa che fu attuata investendo parte del surplus alimentare nelle prime fortificazioni, nell’addestramento di guerrieri autoctoni o nell’assunzione di combattenti stranieri. Tutto ciò rappresenta una catena di cause ed effetti che rese necessario lo sviluppo di società sempre più complesse, professionalmente diversificate e gerarchicamente stratificate. In breve la nascita di società pre-statuali basate su leggi comunemente riconosciute e sul senso di appartenenza etnica, territoriale e culturale.
L’arrivo della scrittura avrebbe permesso alle società stanziali un ulteriore balzo in avanti rispetto alle società nomadi e tribali: la scrittura permise infatti la catalogazione delle risorse, una maggiore efficienza nella trasmissione delle informazioni, un aumento esponenziale della possibilità di calcolo e la possibilità di tramandare la memoria storica della comunità. Non è eccessivo dire che se l’agricoltura ci ha permesso di passare dalle tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori alle società stanziali neolitiche, allora la scrittura ci ha permesso di balzare, in un tempo incredibilmente breve, dai villaggi neolitici alla Stazione Orbitante Internazionale.
Ovviamente ogni evoluzione umana comporta anche un lato negativo. Nel caso della sedentarizzazione fu l’avvento del concetto di guerra di sterminio. Questo perché per una società nomade la guerra consiste essenzialmente nell’espellere un gruppo rivale da un territorio di buona caccia o buoni pascoli e rapirgli le donne, da trasformare in schiave riproduttive con le quali innestare sangue fresco nella comunità. Niente di nuovo dal tipo guerra che ancor oggi i branchi di scimpanzé si fanno tra di loro. Questo tipo di conflitto quasi sempre si concludeva con la migrazione/fuga del gruppo sconfitto o con la sua assimilazione in quello vincitore attraverso la sottomissione gerarchica e sessuale.

L’avvento della società agricola e stanziale, invece, ha imposto ai nostri antenati un cambio di passo. Scopo dei conflitti non era più solo la difesa delle proprie risorse o il furto di quelle altrui, ma il controllo stabile del territorio, poiché con l’agricoltura dal territorio arriva la vita stessa. Questo significava che il nemico diveniva la stessa popolazione avversaria, che essendo anch’essa agricola avrebbe difeso fino alle estreme conseguenze la sua permanenza in un dato luogo. Pertanto, qualora fosse stato impossibile per i vincitori espellere o assimilare gli sconfitti, l’unica soluzione divenne quella radicale: lo sterminio o l’asservimento di massa degli sconfitti.
Un esempio che ci aiuta a capire di cosa stiamo parlando è la caduta di Troia. Nel mito omerico, avente tuttavia solide radici nella storia, cosa fecero i greci quando espugnarono la città nemica? Sterminarono tutti i maschi indifferentemente dall’età (dall’anziano re Priamo al poppante figlio di Ettore, Astianatte) e si spartirono tutte le donne, molte dopo averle violentate persino dentro i templi religiosi. Le anziane divennero schiave di poco valore, mentre quelle in età riproduttiva sarebbero state sottomesse (nel vero senso di sotto messe) ai vincitori, affinché la stessa identità troiana scomparisse attraverso figli cresciuti nell’esaltazione della gloria virile dei padri vincitori. Quella che oggi chiameremmo volontà d’annientamento genetica arriva al punto che Neottolemo, figlio di Achille, prima uccide l’anziano re, poi getta dalle mura l’infante Astianatte, ottiene come concubina nientedimeno che Andromaca, la vedova di Ettore a cui ha assassinato il figlio, ed infine con la nuova preda genera tre figli, uno dei quali, Molosso, sarà il mitico progenitore di un popolo guerriero.
Tutto ciò (nel mito come nella realtà) è stato generato dall’incredibile accelerazione socio-organizzativa delle comunità agricole neolitiche: agricoltura quindi necessità di difendere stabilmente il territorio; creazione di una classe guerriera professionale da mantenere tramite il surplus economico; necessità di strutture politiche che organizzassero comunità sempre più complesse; professioni sempre più specializzate; invenzione della scrittura per catalogare i beni e corrispondere i servizi. In breve l’uomo aveva inventato lo Stato.
Nella storia umana due sono gli Stati per antonomasia: Roma antica e Cina imperiale. Certo fino all’era moderna non sono mancati altri modelli di statualità, ma oggi, con la parziale e variegata eccezione del mondo islamico, il mondo si governa utilizzando organizzazioni che altro non sono che l’evoluzione di quei due supremi modelli. Roma e la Cina sono i due esempi paradigmatici non solo per il loro successo, ma anche perché tra di loro, curiosamente, le similitudini si equivalgono alle differenze.
Entrambe furono potenze essenzialmente terrestri, che si lanciarono in mare solo occasionalmente e tutto sommato controvoglia, malgrado i buoni risultati ottenuti. Entrambe, una volta raggiunti confini geograficamente razionali, commisero l’errore di fermare volontariamente la loro espansione con relativa assimilazione etno-culturale dei popoli sottomessi. Entrambe, infine, hanno plasmato il concetto stesso di sistema di vita nelle rispettive estremità del continuum terrestre eurasiatico.

Tuttavia, anche le differenze non furono da poco. Roma ebbe un mito fondativo leggendario e parzialmente mitologico (Romolo), mentre la Cina ebbe un primo imperatore storicamente esistito che unificò manu militari regni all’epoca molto diversi tra di loro. Roma riconobbe fin da subito il suo debito culturale verso la Grecia e in parte verso l’Etruria, mentre la Cina se si eccettua l’importazione del buddhismo indiano ebbe sempre la pretesa/arroganza di considerarsi l’unica “madre del mondo”. La superiore capacità dell’Occidente di assimilare, esplorare ed inventare, probabilmente, deriva da questo.
Roma, infine, prima attraverso la religione pagana e poi con l’avvento del cristianesimo, ebbe sempre una visione dello Stato laico ma simbiotico con la religione. La Cina invece, pur mantenendo il “sottobosco” della religione popolare taoista, è stata caratterizzata da confucianesimo e buddhismo. Queste due fedi, soprattutto il confucianesimo, più che delle vere e proprie religioni sono delle strutture morali sui quali costruire una società ordinata e strettamente gerarchizzata. Ne consegue che la società cinese, pur avendo enorme rispetto per i rituali, gli antenati e tutto ciò che sia riconducibile alla gerarchia, resti una società essenzialmente atea, dove la divinità è lo Stato stesso.
La capacità del comunismo sinico di sopravvivere al XX secolo e di immettersi nella continuità della tradizione dinastico-imperiale cinese… è tutta qui.