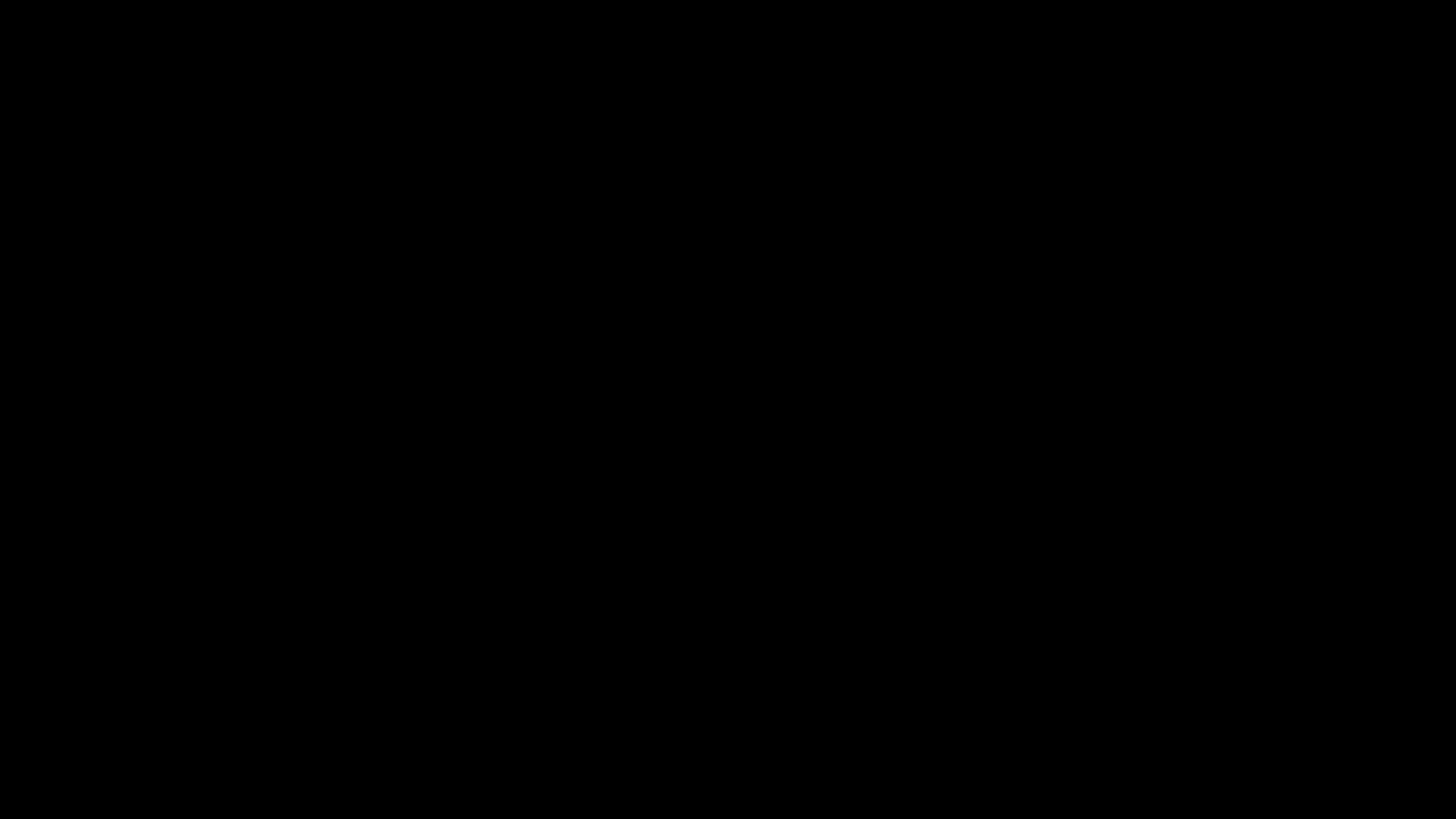L’opposizione interna in Iran
Pietro Licciardi intervista Hanieh Tarkian e Parisa Pasandehpoor
| Parisa Pasandehpoor, nata in Iran nel 1979, vive da 12 anni a Genova. Laureata in economia e commercio, laureanda in scienze politiche internazionali diplomatiche. Attivista per i diritti delle donne e soprattutto di quelle iraniane. Giornalista free lance presso www.Irangate.news Lavora anche nel settore contabile amministrativo in una società privata. | Hanieh Tarkian, Italo-iraniana. Ha completato il dottorato in Scienze Islamiche presso il Jamiat az-Zahra, il più importante centro femminile di studi islamici dell’Iran. Ha conseguito un Master in Relazioni Internazionali e Studi Strategici ed è attualmente docente e coordinatrice del Master in lingua italiana in Studi Islamici organizzato dall’Università internazionale Al-Mustafa (Iran). |
Si ringrazia la dottoressa Arianne Ghersi per la meticolosa gestione della comunicazione con le intervistate
Quanto è estesa l’opposizione al governo confessionale dell’Iran? In Occidente, attraverso i nostri media sappiamo delle manifestazioni di piazza che periodicamente rivendicano maggiore libertà, anche nei costumi. Più di recente abbiamo saputo delle proteste contro il velo da parte delle donne. Si tratta di una opposizione evidentemente di matrice laica.
Ma vi è anche una opposizione di tipo religioso? L’islam sciita in fondo sembra meno dogmatico di quello sunnita e la stretta osservanza coranica degli ayatollah oggi al potere potrebbe non essere condivisa da tutte le guide religiose.
Hanieh:
La maggior parte del popolo iraniano non è contrario all’ordinamento della Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica è stata istituita con un referendum che ha visto il “sì” con il 98% dei voti e la sua esistenza non sarebbe possibile senza il sostegno del popolo, come non sarebbe stata possibile la rivoluzione senza il sostegno del popolo. Questo appoggio viene ribadito ogni anno in varie occasioni importanti, come l’anniversario della Rivoluzione, in cui milioni di iraniani scendono in piazza a sostegno dell’ordinamento. Anche dopo le varie proteste degli ultimi anni, che spesso si trasformavano in caos e violenza, gli iraniani manifestavano a sostegno dell’ordinamento e contro la violenza dei gruppi di opposizione.
Quindi queste proteste sono promosse da una minoranza. Questa minoranza è sostenuta da agenti esterni, dalla propaganda mediatica dei canali globalisti ed economicamente da enti come la CIA e Open Society di Soros. Tra coloro che partecipano a queste proteste, ci sono i membri di gruppi separatisti e terroristici curdi e del MEK. Ma questi gruppi, e in particolare il MEK, non godono di alcun sostegno da parte della società iraniana.
Se c’è del malcontento questo è più che altro dovuto ai problemi economici, non tanto a questioni legate alla religione o al codice di abbigliamento, e i problemi economici sono aggravati dalle ingiuste sanzioni imposte all’Iran.
Sicuramente riguardo a molte questioni, compreso ciò che riguarda il velo e il codice di abbigliamento, il dialogo e il dibattito esistono in Iran, come riguardo qualsiasi altra questione, ricordiamo che almeno due dei presidenti iraniani, Khatami e Ruhani, erano chierici con una visione filo-occidentale della politica. La varietà e la libertà di opinioni in campo politico sono sempre stati presente in Iran.
Parisa:
Sì, accanto all’opposizione di matrice laica, esiste anche una forma di opposizione religiosa al governo iraniano, sebbene meno visibile nei media occidentali. Questa opposizione nasce da ambienti religiosi che contestano l’interpretazione teocratica e autoritaria dell’Islam imposta dal regime.
1. Religiosi riformisti e tradizionalisti
- Alcuni ayatollah e studiosi sciiti, anche di alto livello, non condividono il concetto di “velayat-e faqih” (il governo del giurista islamico), su cui si basa la Repubblica islamica.
- Alcuni sostengono una separazione tra religione e potere politico, o comunque una gestione del potere più democratica e meno autoritaria.
2. Spiritualismo alternativo
- In Iran esistono correnti religiose mistiche o sufi, come i dervisci Gonabadi, che sono stati perseguitati perché non allineati con la versione ufficiale dell’Islam sciita duodecimano del regime.
- Questi gruppi criticano la politicizzazione della fede e rivendicano una religiosità più personale, interiore e non imposta.
3. Critiche dal basso
Anche tra i credenti comuni, molti musulmani praticanti si oppongono al regime non perché rifiutino l’Islam, ma perché ritengono che l’attuale governo tradisca i principi religiosi autentici, come la giustizia, l’onestà e la compassione.
Riguardo islam sciita e sunnita, hai colto un punto importante. In effetti, l’Islam sciita possiede al suo interno una maggiore flessibilità interpretativa rispetto a quello sunnita, almeno sul piano teorico e giuridico. Questo perché:
1. Ruolo del ragionamento giuridico (ijtihad)
- Nell’Islam sciita, l’ijtihad — ovvero lo sforzo di interpretazione individuale dei testi sacri — è centrale e riconosciuto come strumento per adattare la legge islamica alle circostanze.
- Ogni marja’ (guida religiosa suprema) può emettere proprie opinioni giuridiche, anche diverse da quelle di altri. Questo crea un pluralismo interpretativo interno.
2. Non tutti i religiosi sciiti sostengono il potere degli ayatollah
- Il principio del velayat-e faqih (governo del giurista islamico) su cui si fonda la Repubblica Islamica non è universalmente accettato nemmeno tra gli sciiti.
- Alcuni importanti ayatollah, in Iran e in Iraq (come in ambito della scuola di Najaf), rifiutano l’idea che un religioso debba esercitare direttamente il potere politico.
3. Il contrasto attuale
- L’attuale élite al potere in Iran impone una lettura rigida e ideologizzata dell’Islam, ma molti religiosi — anche senza essere riformisti o laici — contestano il modo in cui la religione viene strumentalizzata.
- Quindi sì, la “stretta osservanza coranica” degli ayatollah al potere è tutt’altro che unanime nel mondo sciita, ed esistono voci interne che promuovono visioni più etiche, spirituali e meno autoritarie della fede.
L’opposizione interna è in grado di favorire un reale cambiamento interno del Paese o è ancora troppo debole, nonostante l’attenzione che riceve dai media occidentali?
Parisa:
È una domanda centrale, e la risposta richiede una distinzione tra potenzialità e condizioni reali.
1. L’opposizione interna ha un forte potenziale
- Il malcontento è diffuso, soprattutto tra giovani, donne, classi urbane e minoranze etniche e religiose.
- I movimenti come quello di “Donna, vita, libertà” hanno dimostrato una profonda rottura culturale con il sistema.
- La distanza tra società e governo è sempre più ampia, e ciò indica un desiderio reale di cambiamento.
2. Ma il cambiamento è frenato da fattori strutturali
- La repressione è brutale ed efficiente: il regime dispone di apparati di sicurezza capillari, processi sommari, carcere e censura.
- L’opposizione è ancora frammentata e senza una leadership unificata, né una strategia politica chiara per la transizione.
- Non esiste un movimento coordinato capace di trasformare la protesta sociale in un progetto politico organizzato.
3. Il ruolo dei media occidentali
- L’attenzione mediatica aiuta a proteggere simbolicamente i manifestanti, a denunciare le violazioni e a legittimare le loro richieste.
- Tuttavia, non basta: senza pressioni internazionali più efficaci e senza sostegno reale alla società civile, l’effetto resta più simbolico che pratico.
Hanieh:
La così detta opposizione è debole e non è in grado di favorire nessun cambiamento sistematico. Una delle principali debolezze dell’opposizione, sia interna che all’estero, è la mancanza di una leadership e di unità d’intenti nel presentare una visione alternativa o un piano programmatico. Inoltre le figure d’opposizione tradizionali, come il figlio dell’ex-Scià o il MEK, non godono di sostegno reale all’interno dell’Iran.
L’attenzione che l’opposizione riceve dai media occidentali è parte della propaganda contro l’Iran che ormai dura da più di quarant’anni. Le azioni dell’opposizione, spesso incoraggiate e sostenute da forze esterne, sono volte a destabilizzare il paese attraverso violenza e vandalismo, trasformando le proteste in “guerriglia urbana”, piuttosto che a promuovere un cambiamento interno guidato dalla volontà popolare.
Quali effetti potrebbe avere un eventuale intervento militare straniero in Iran? Pensiamo a Israele, che è disposto a tutto pur di impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari e alle minacce, anche recenti, degli Stati Uniti. Il popolo iraniano di fronte ad una eventuale escalation si ricompatterebbe attorno al proprio governo, rafforzandolo, o il conflitto potrebbe innescare un cambio ai vertici dello Stato?
Hanieh:
Un eventuale intervento militare straniero contro l’Iran porterebbe a maggiore unità tra i membri della popolazione iraniana, rafforzando di fatto l’ordinamento. Il popolo iraniano è molto orgoglioso e coraggioso, e la sua storia, come la guerra imposta dall’Iraq sostenuto da potenze esterne, dimostra la sua capacità di resistere e di unirsi di fronte alle aggressioni, anche con risorse limitate.
I funzionari iraniani hanno sempre affermato di non cercare l’escalation o la guerra, ma difenderanno l’Iran da qualsiasi aggressione. Un attacco contro l’Iran o il sostegno a Israele/USA in tale attacco comporterebbe una forte reazione da parte dell’Iran. Stati Uniti e Israele sono forze destabilizzanti nella regione, interessate a mantenere uno stato di caos per implementare i propri interessi. La risposta iraniana ai recenti attacchi di Israele ha dimostrato la forza e la preparazione dell’Iran, mettendo in difficoltà i suoi avversari.
Le linee generali della politica iraniana, inclusa la salvaguardia dell’indipendenza nazionale, la lotta contro le potenze imperialiste e le ingerenze straniere, sono condivise dalla maggior parte degli iraniani. Un conflitto voluto dall’esterno non può innescare un cambio ai vertici dello Stato, al contrario, il popolo iraniano, anche chi oggi critica il velo, si unirebbe per difendere la propria patria di fronte a minacce esterne.
Parisa:
Un eventuale intervento militare straniero in Iran, soprattutto da parte di potenze come Israele o gli Stati Uniti, avrebbe conseguenze profonde e complesse — non necessariamente favorevoli al cambiamento democratico. Gli effetti probabili si possono riassumere in due scenari principali:
1. Ricompattamento nazionale attorno al regime
- Storicamente, il popolo iraniano — pur critico verso il proprio governo — tende a reagire con orgoglio e unità nazionale di fronte a minacce esterne. L’intervento straniero verrebbe visto da molti come una violazione della sovranità nazionale, anche da parte di oppositori del regime.
- Il governo potrebbe strumentalizzare l’attacco per legittimarsi, rafforzando il discorso patriottico e repressivo: “In tempi di guerra, non c’è spazio per il dissenso.”
- La repressione interna aumenterebbe drasticamente, giustificata dall’emergenza e dal pretesto della sicurezza nazionale.
2. Possibile destabilizzazione del regime (con molti rischi)
- Un intervento militare potrebbe indebolire le strutture del potere, soprattutto se colpisce infrastrutture chiave o centri decisionali del regime.
- Il caos successivo potrebbe aprire a scenari imprevedibili:
- guerra civile,
- radicalizzazione di gruppi armati,
- ulteriore crisi economica e umanitaria,
- aumento dell’influenza di potenze esterne (Russia, Cina, ecc.).
- Senza una forza politica interna organizzata e legittimata, potrebbe seguire una fase di grave instabilità: guerra civile, crisi umanitaria, rafforzamento di attori esterni o gruppi estremisti.
3. Ma oggi c’è un elemento nuovo e significativo:
Oggi, una parte crescente del popolo iraniano è così stanca e frustrata per la drammatica situazione economica, politica e culturale, che alcuni potrebbero non respingere con forza l’idea di un attacco straniero.
Non si tratta di un consenso attivo verso l’intervento, ma piuttosto di una disperazione profonda, che fa vedere anche il rischio estremo come una possibile via di uscita da un sistema percepito come insostenibile.
Questo sentimento non è generalizzato, ma sta emergendo con maggiore frequenza, soprattutto tra i giovani.